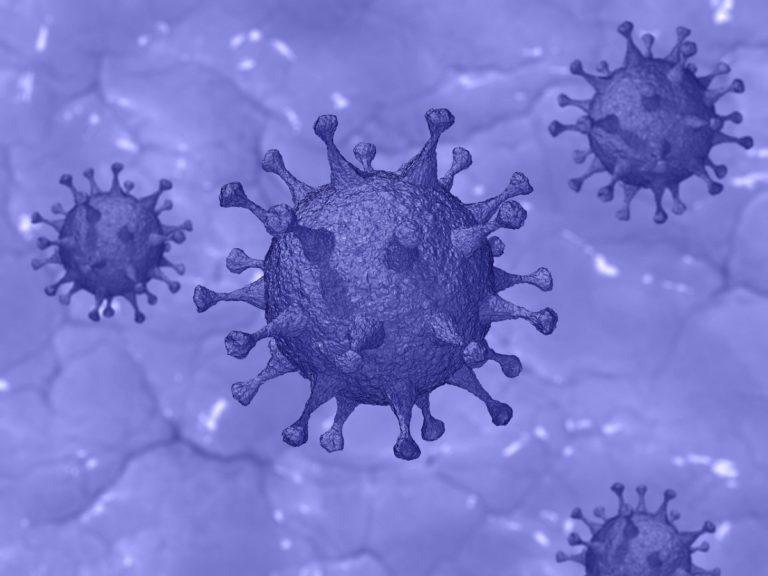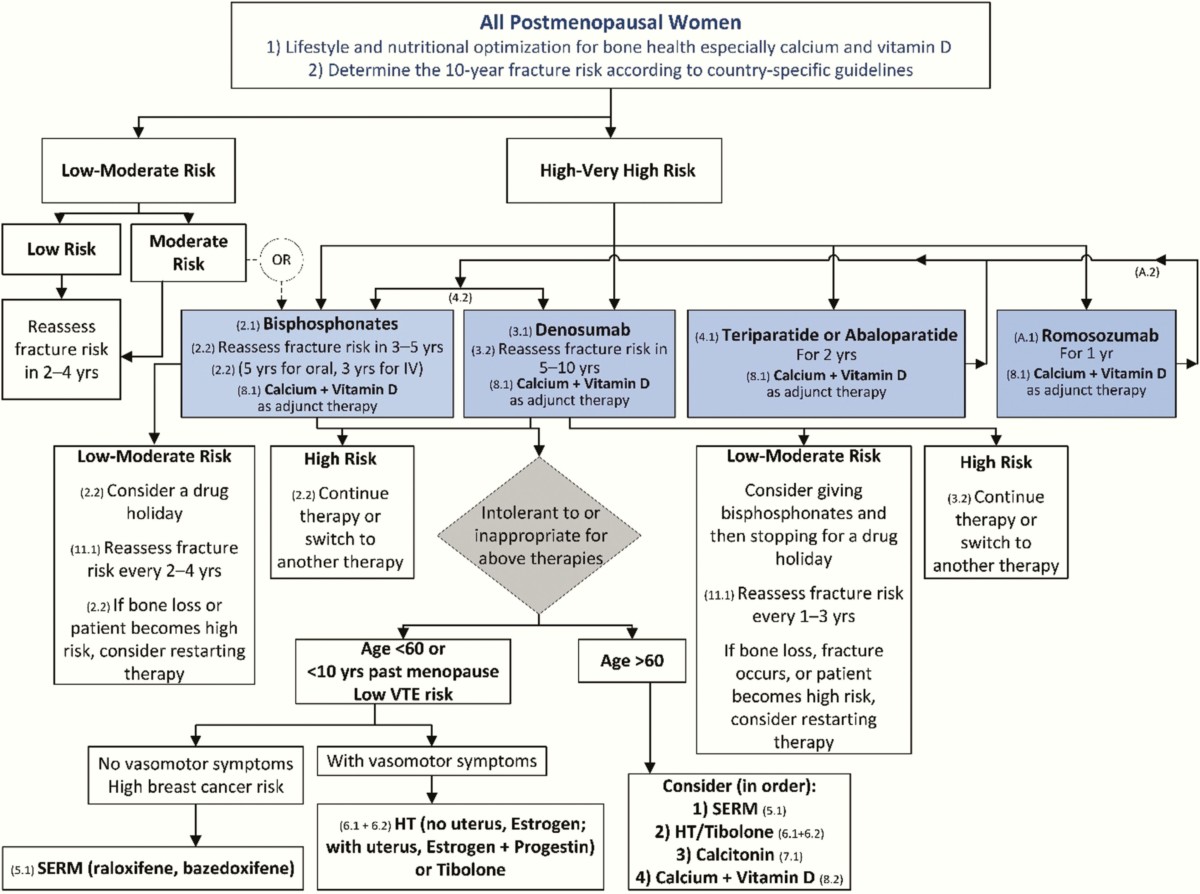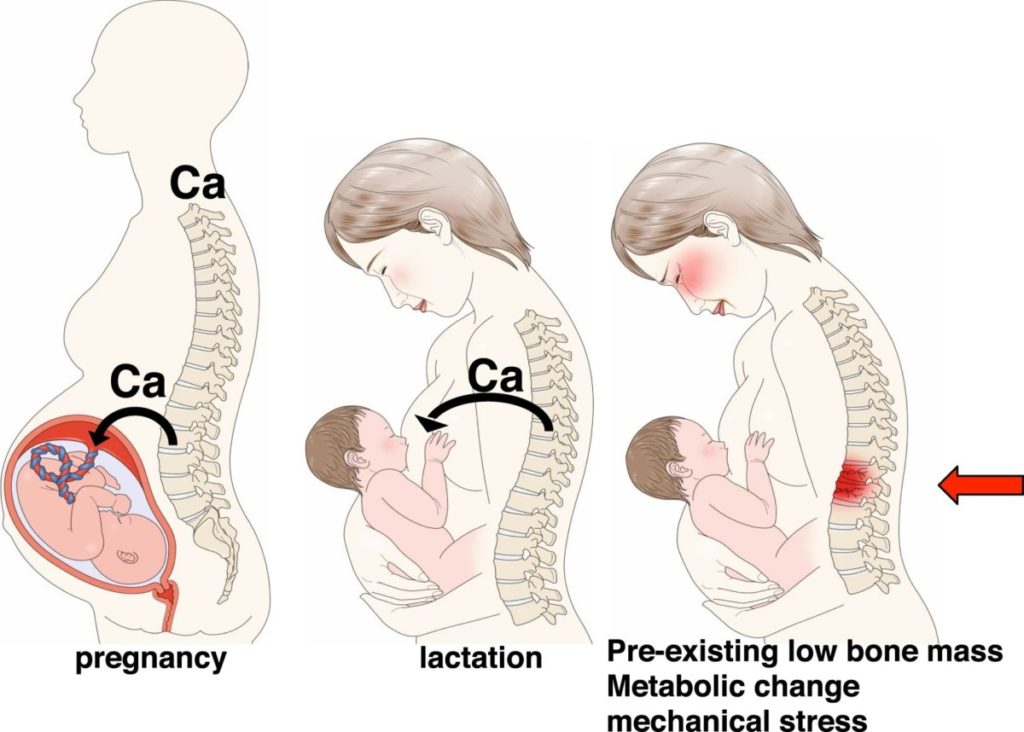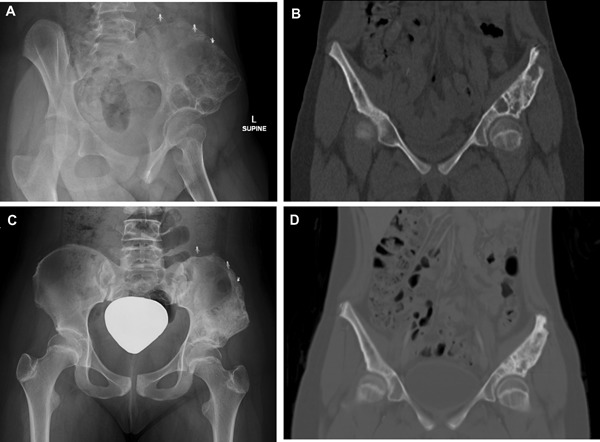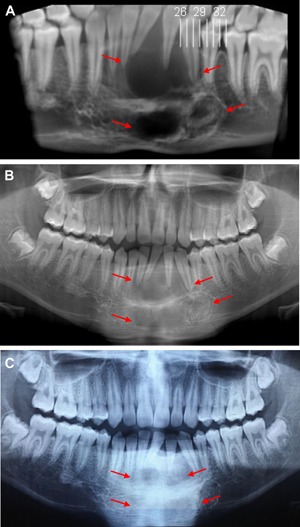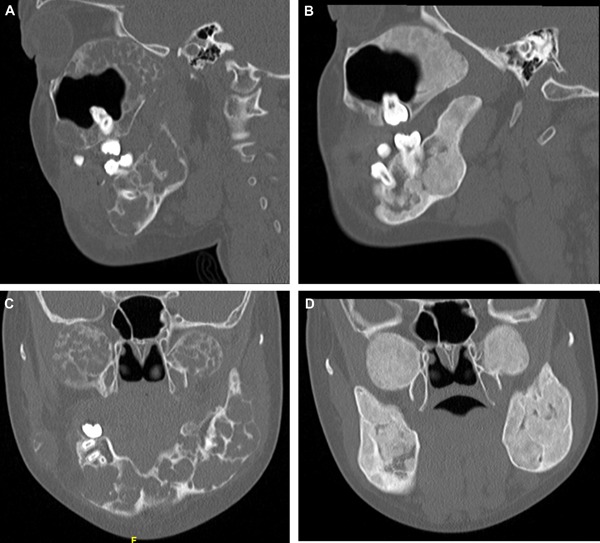Ricercatori dell’Ospedale universitario Fundación Jiménez Díaz di Madrid hanno effettuato una review della letteratura pubblicata sul Journal of Osteoporosis per studiare gli effetti della carenza di vitamina K, della supplementazione di vitamina K e dell’assunzione di anticoagulanti orali antagonisti della vitamina K su diversi parametri ossei. I ricercatori hanno preso in considerazione articoli che analizzano gli aspetti rilevanti della relazione tra vitamina K e salute delle ossa presenti nei database PubMed, Medline e Cochrane.
Sebbene sia nota per la sua importanza nella cascata della coagulazione, la vitamina K ha anche altre funzioni. Poiché prende parte alla carbossilazione di molte proteine correlate alle ossa, regola la trascrizione genetica dei marker osteoblastici e regola il riassorbimento osseo, la vitamina K è essenziale alla salute delle ossa.
La carenza di vitamina K non è rara, poiché l’organismo non è in grado di produrne in quantità sufficienti e deve essere assunta con la dieta. Inoltre anche l’assunzione di anticoagulanti orali dell’antagonista della vitamina K induce carenza di vitamina K. La maggior parte degli studi rileva che basse concentrazioni sieriche di K1, alti livelli di osteocalcina carbossilata (ucOC) e un basso apporto dietetico di K1 e K2 sono associati a un rischio maggiore di fratture e a una densità di massa ossea (BMD) inferiore.
Gli studi relativi alla relazione tra la supplementazione di vitamina K e il rischio di frattura rilevano che assumendo integratori si potrebbe ridurre il rischio di fratture, ma sono necessari studi appositamente progettati che prevedano come endpoint primario la frattura.
Anche la riduzione del rischio di frattura con l’uso di anticoagulanti orali non antagonisti della vitamina K (NOAC) al posto del warfarin è interessante, ma ancora una volta le prove disponibili offrono risultati difformi. Le prove scarse e limitate, inclusi studi di bassa qualità che hanno raggiunto conclusioni discordanti, rendono impossibile trarre solide conclusioni su questo argomento, in particolare per quanto riguarda l’uso di integratori di vitamina K.
Vitamina K, fratture e densità minerale ossea
La maggior parte degli studi rileva che basse concentrazioni sieriche di K1, alti livelli di osteocalcina non carbossilata (ucOC) e un basso apporto dietetico di K1 e K2 sono associati a un maggior rischio di fratture.
La correlazione tra assunzione di vitamina K attraverso la dieta e il rischio di fratture ha evidenze sostanziali. Uno dei più grandi studi in materia è l’analisi prospettica risalente al 1999 “Vitamin K intake and hip fractures in women: a prospective study” condotta nell’ambito dello Nurse’ Health Study effettuata su 72.327 donne di età compresa tra 38 e 74 anni, con un follow-up di 10 anni. In questo studio, i soggetti con un apporto di vitamina K1 superiore a 109 μg/die hanno presentato un rischio relativo di frattura dell’anca significativamente inferiore aggiustato per età rispetto alle donne con un apporto inferiore (RR: 0,70; intervallo di confidenza al 95% (CI): 0,53, 0,93 ). L’assunzione di dosi più elevate di vitamina K non ha apportato nessun ulteriore beneficio nella riduzione di fratture, anzi sembra esistere una soglia oltre la quale il rischio di fratture inizia a salire.
La meta-analisi “Vitamin K intake and the risk of fractures: a meta-analysis” del 2017 che includeva quattro studi di coorte e uno studio di case-control nidificato, sommando un totale di 80.982 partecipanti e 1114 fratture ha mostrato una proporzionalità inversa tra l’assunzione di vitamina K1 con la dieta e il rischio di fratture, senza trovare alcun “effetto soglia”. In questo studio, i soggetti con il più alto apporto di vitamina K hanno presentato una riduzione del 22% nel rischio di fratture (IC 95%: 0,56-0,99), ma vale la pena ricordare che tra gli studi è stata riscontrata una moderata eterogeneità. L’analisi dei sottogruppi ha mostrato che solo studi con un follow-up di dieci o più anni hanno trovato questa associazione.
Se una maggior assunzione di vitamina K sia associata a valori di BMD più alti è ancora una questione controversa. Sebbene l’assunzione di vitamina K con la dieta sia stata collegata a un minor rischio di frattura, i risultati dell’effetto sulla BMD sono più incoerenti. Ad esempio, usando la Framingham study cohort, Booth et al. nello studio “Dietary vitamin K intakes are associated with hip fracture but not with bone mineral density in elderly men and women“, pubblicato nel maggio del 2000 su The American Journal of Clinical Nutrition hanno analizzato la variazione della BMD in sei siti anatomici di 888 pazienti con un’età media di 75 anni con assunzioni PK diverse valutate attraverso un questionario validato sulla frequenza alimentare. Gli autori non hanno trovato un’associazione significativa tra BMD in nessun sito e assunzione di PK, nonostante la correzione di potenziali variabili confondenti come l’età, l’indice di massa corporea, il consumo di fumo/alcol, altre assunzioni dietetiche (calcio e vitamina D) e l’uso di estrogeni. Tuttavia, hanno trovato un’associazione significativa tra l’assunzione di PK e le fratture, suggerendo che questo evento è stato mediato da fattori diversi dalla perdita di BMD. Gli stessi autori hanno pubblicato tre anni dopo “Vitamin K intake and bone mineral density in women and men”, questa volta includendo 2591 individui, con un’età media più giovane (rispettivamente 58 e 59 anni per donne e uomini). In questa analisi, un basso apporto di PK ha mostrato un’associazione indipendente dall’età con BMD all’anca e alla colonna vertebrale, ma solo nelle donne. Gli autori non possono giustificare questi risultati con la differenza di età tra le due coorti, ma suggeriscono piuttosto che il maggior numero di partecipanti può spiegare la variazione dei risultati. Inoltre, uno studio del 2016 che ha coinvolto una coorte di donne danesi in perimenopausa non ha trovato alcuna associazione tra assunzione di K1 e BMD al collo del femore o alla colonna lombare.
Nel complesso, sono ignote le ragioni alla base dei risultati contraddittori relativi agli effetti che l’assunzione di vitamina K ha sui parametri ossei.
Un problema può essere ricondotto al fatto che molti studi si limitano a valutare solamente l’assunzione di vitamina K1, che è la forma principale presente nella dieta, senza considerare che anche l’assunzione di vitamina K2 può rappresentare una variabile importante.
Un’altra difficoltà è che l’assunzione di vitamina K viene mal correlata ai cambiamenti nelle concentrazioni sieriche. Nello studio “Associations between Vitamin K Biochemical Measures and Bone Mineral Density in Men and Women” Booth et al. hanno valutato la presenza di vitamina K attraverso i valori plasmatici di K1 e i valori sierici di osteocalcina non carbossilata (under-γ-carboxylated osteocalcin ucOC). Nello studio, che ha coinvolto 863 donne e 741 uomini senza differenze significative nell’assunzione di K1 media (151-177 μg/giorno), uno stato di vitamina K scarso è stato associato a BMD bassa al collo del femore negli uomini e BMD bassa alla colonna vertebrale nelle donne senza terapia sostitutiva con estrogeni. Questa associazione non era significativa nelle donne in premenopausa o postmenopausa con terapia sostitutiva con estrogeni. Pertanto, questo studio evidenzia l’importanza di regolare i risultati per variabili come lo stato degli estrogeni. Infine, nel piccolo studio “Relation Between Circulating Vitamin K1 and Osteoporosis in the Lumbar Spine in Syrian Post-Menopausal Women” condotto da Jaghsi et al. nelle donne in postmenopausa senza terapia sostitutiva con estrogeni, il K1 sierico era positivamente correlato alla BMD della colonna lombare. La sensibilità diagnostica e la specificità dei valori di vitamina K1 per l’osteoporosi erano rispettivamente del 90% e del 98% e gli autori propongono che la vitamina sierica K1 potrebbe essere utile come strumento diagnostico per l’osteoporosi.
Una limitazione importante a questi studi è la difficoltà di regolare i risultati per le variabili confondenti. Gli alimenti ricchi di vitamina K possono veicolare anche altri nutrienti “amici” delle ossa (calcio, magnesio ecc.) che possono interferire con i risultati.
Alla luce degli studi riportati, sembra che i valori di ucOC siano un buon indicatore della salute delle ossa.
Effetto della supplementazione di vitamina K su fratture e BMD
Gli effetti della supplementazione di vitamina K sulla BMD sono riassunti nella meta-analisi “Effect of vitamin K on bone mineral density: a meta-analysis of randomized controlled trials” eseguita da Fang et al., che comprendeva sia soggetti sani che pazienti affetti da osteoporosi primaria/secondaria. In totale, sono stati inclusi 17 studi, dieci dei quali includevano integratori di vitamina K2 (otto con MK-4 alla dose di 15–45 mg/die e due con MK-7 alla dose di 0,2-3,6 mg/die) e sette studi con supplementazione di vitamina K1 (0,2-10 mg/die). Nell’analisi generale, inclusi tutti gli studi selezionati, gli autori hanno scoperto che l’integrazione di vitamina K non ha influenzato significativamente la BMD (misurata in base alla differenza media ponderata) al collo del femore, ma ha aumentato significativamente la BMD della colonna lombare dell’1,27% (IC 95%: 0,47– 2,06) dopo 6–36 mesi di trattamento. Tuttavia, quando le analisi dei sottogruppi sono state eseguite in base al tipo di vitamina K somministrata, gli effetti non erano significativi per K1 e rimanevano comunque significativi per K2 (aumento medio dell’1,8% della BMD della colonna lombare, CI 95%: 0,87–2,75). Gli autori sono cauti su questi risultati; molti degli studi inclusi erano di bassa qualità ed è stata riscontrata una significativa eterogeneità tra questi studi.
Un’altra meta-analisi (“Does vitamin K2 play a role in the prevention and treatment of osteoporosis for postmenopausal women: a meta-analysis of randomized controlled trials“) ha esplorato specificamente il ruolo degli integratori di vitamina K2 sia nella BMD che nella frattura. Attraverso 19 studi (11 dei quali non sono stati inclusi nella meta-analisi sopra menzionata) con 6759 partecipanti, gli autori hanno scoperto che i supplementi di K2 hanno migliorato significativamente la BMD vertebrale a medio e lungo termine e la BMD dell’avambraccio a lungo termine in donne in postmenopausa con osteoporosi.
Infine, lo studio “Possible site-specific effect of an intervention combining nutrition and lifestyle counselling with consumption of fortified dairy products on bone mass: the Postmenopausal Health Study II” condotto su 115 donne in postmenopausa ha dimostrato che tutti e tre i gruppi che avevano assunto rispettivamente integratori contenenti calcio e vitamina D; calcio, vitamina D e vitamina K1; calcio, vitamina D e vitamina K2 per un anno avevano mostrato un aumento significativo della BMD totale rispetto ai controlli, con ulteriori vantaggi per la BMD lombare nei gruppi che hanno assunto K1 o K2.
In generale, la maggior parte degli studi riporta una correlazione positiva, almeno in alcuni sottogruppi, tra l’assunzione di integratori di vitamina K e aumento della BMD.
Inoltre, sebbene alcuni studi non abbiano dimostrato cambiamenti significativi nella BMD, sono riusciti a ottenere risultati significativi in altri parametri ossei.
I ricercatori concludono che l’integrazione con vitamina K sembra ridurre le fratture, ma che è necessario uno studio ampio e di alta qualità per confermare questi risultati al fine di formulare una raccomandazione specifica.
Effetto della supplementazione di vitamina K in associazione con altri trattamenti finalizzati al trattamento dell’osteoporosi
Le prove in materia sono scarse, soprattutto per quanto riguarda l’effetto sulle fratture. Il più grande studio che affronta questo problema è “Comparison of concurrent treatment with vitamin K2 and risedronate compared with treatment with risedronate alone in patients with osteoporosis: Japanese Osteoporosis Intervention Trial-03” che ha coinvolto 1874 donne di età pari o superiore a 65 anni con osteoporosi, che sono state sottoposte a terapia con risedronato e vitamina K2 o solo risedronato. I tassi di incidenza della frattura erano simili tra i due gruppi e l’analisi dei sottogruppi non ha dimostrato differenze quando i pazienti sono stati stratificati su valori sierici di ucOC.
Altri studi più piccoli hanno portato a risultati contraddittori e i ricercatori concludono che gli integratori di vitamina K non possono essere raccomandati per il trattamento dell’osteoporosi, almeno nei soggetti che non sono a rischio di carenza di vitamina K per motivi specifici.
Nuovi anti coagulanti orali (NOAC) e fratture
La terapia con antagonisti della vitamina K (VKA) causa carenza di vitamina K, bloccando l’enzima vitamina K epossido reduttasi, esaurendo così la vitamina K idrochinone che è essenziale per l’attività della glutamil carbossilasi e quindi rappresenta una potenziale minaccia per la salute delle ossa attraverso questo meccanismo. Tuttavia, l’evidenza disponibile sull’effetto della VKA sulla frattura offre risultati contraddittori, con alcuni studi che riportano un aumento del rischio di frattura in siti diversi (tranne l’anca) e altri no. Questi risultati possono essere imputati ai limiti di questi studi, ad esempio un breve follow-up degli individui inclusi in essi o la valutazione delle fratture solo in alcuni siti.
La prescrizione di NOAC è notevolmente aumentata negli ultimi anni in alternativa ai VKA e, al contrario di questi ultimi, i NOAC non interferiscono con il ciclo della vitamina K. Sono state pubblicate prove che esplorano il loro profilo di sicurezza ossea, sia nei ratti che nell’uomo.
Gli studi che esplorano l’effetto dei NOAC nei ratti suggeriscono un profilo favorevole di sicurezza ossea; sono state anche pubblicate prove relative al profilo di sicurezza ossea di NOAC negli esseri umani, ma non esiste un singolo studio controllato randomizzato che ne valuti l’esito primario.
Alla luce degli studi analizzati dai ricercatori, è chiaro che è necessario uno studio controllato randomizzato che paragoni il rischio di fratture tra chi assume NOAC e chi assume VKA. Fino ad allora, non è possibile trarre alcuna conclusione solida sul profilo di sicurezza ossea dei NOAC a causa di prove limitate e disparate.
Limitazioni delle prove disponibili
Le differenze nei risultati tra gli studi possono essere influenzate da molti fattori confondenti, tra cui le diverse forme di vitamina K utilizzate, l’assunzione di vitamina K nella dieta di base dei soggetti inclusi, il livello di assunzione con la dieta di calcio e vitamina D, l’uso di altri integratori e differenze nelle caratteristiche basali della popolazione.
Conclusioni
La vitamina K svolge un ruolo importante nella salute delle ossa. Negli studi osservazionali, una bassa assunzione di vitamina K, bassi valori sierici di vitamina K e alti livelli di osteocalcina non carbossilata circolatoria (ucOC) sono associati al rischio di frattura (in particolare frattura dell’anca). Tuttavia, gli studi clinici non ottengono risultati conclusivi e, pertanto, sussistono ancora controversie sull’uso degli integratori di vitamina K1 e K2.
Sono necessari studi clinici di alta qualità su pazienti con bassi valori sierici di vitamina K e/o basso apporto dietetico per chiarire il ruolo della vitamina K nel rischio di fratture.
Lo studio
Celia Rodríguez-Olleros Rodríguez, Manuel Díaz Curiel, Vitamin K and Bone Health: A Review on the Effects of Vitamin K Deficiency and Supplementation and the Effect of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants on Different Bone Parameters, Journal of Osteoporosis, 2019, https://doi.org/10.1155/2019/2069176
Articoli correlati
Vitamina K1, K2 e K3