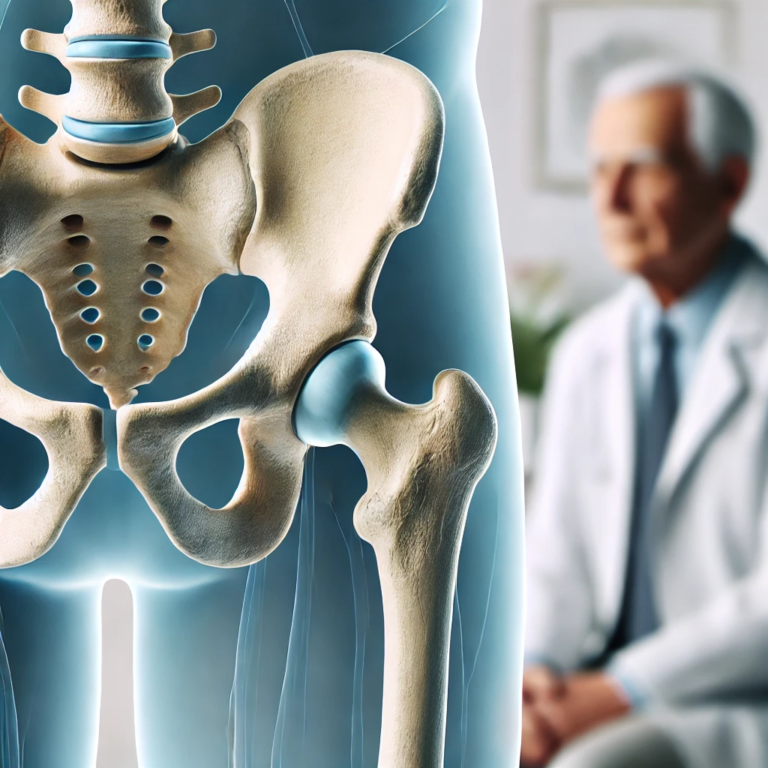Secondo i dati pubblicati a novembre 2024 dall’ Agenzia Italiana del Farmaco sull’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali. L’uso dei farmaci in Italia, nel 2023 si è osservata una netta inversione di tendenza nel consumo dei farmaci per l’osteoporosi, comprendenti vitamina D e suoi metaboliti.
Per la prima volta dopo anni di costante crescita, le dosi erogate sono diminuite dell’11,9%, portandosi a 140,7 DDD (Defined Daily Dose) per 1000 abitanti al giorno.
In parallelo, la spesa complessiva si è ridotta del 2,9%, attestandosi a poco meno di 540 milioni di euro, pari a una spesa pro capite di 9,11 euro. Questa diminuzione è da attribuire principalmente al calo nella prescrizione di vitamina D e dei suoi analoghi per il trattamento dell’osteoporosi.
L’impatto dell’uso off-label di vitamina D e analoghi
Nonostante la contrazione di circa il 15% della spesa e della DDD, vitamina D e suoi analoghi rimangono i farmaci più prescritti, coprendo circa il 45% e l’87% dell’intera categoria. Questi dati confermano l’utilizzo di colecalciferolo e metaboliti per indicazioni extra-scheletriche, per le quali gli studi clinici randomizzati (RCT) non hanno sempre fornito evidenze di efficacia. Tra il 2014 e il 2023, infatti, i consumi di vitamina D hanno registrato un aumento medio annuale del 5,3%, suggerendo un utilizzo talvolta non allineato alle evidenze scientifiche disponibili.
La crescita delle terapie monoclonali e dei bifosfonati
Mentre l’utilizzo della vitamina D diminuisce, gli anticorpi monoclonali (denosumab, burosumab e romosozumab), stanno guadagnando terreno. Nel 2023, il romosozumab, somministrato mensilmente per via sottocutanea, ha registrato un aumento superiore al 100%, divenendo uno dei farmaci più costosi della categoria, con un costo medio per DDD di 14,01 euro. Anche i bifosfonati e il teriparatide mostrano una crescita nei consumi del 5,5% e del 15,7% rispettivamente, a conferma di un orientamento verso terapie più mirate e innovative.
Disparità di genere e d’età nell’uso dei farmaci per l’osteoporosi
La prevalenza d’uso dei farmaci per l’osteoporosi rimane significativamente più elevata tra le donne rispetto agli uomini, con un picco tra gli over 75, dove circa il 50% delle donne riceve una terapia contro il 20% degli uomini. La mediana dell’età degli utilizzatori di questi farmaci è di 69 anni, con un range che va dai 67 anni per i modulatori selettivi del recettore degli estrogeni ai 74 anni per i bifosfonati e denosumab. La differenza di genere è particolarmente rilevante, con una prevalenza d’uso di circa 3,5 volte maggiore nelle donne (18% contro 5% negli uomini).
Differenze geografiche nel consumo e nella spesa
A livello territoriale, il Nord Italia presenta un consumo medio giornaliero di 152,4 DDD/1000 abitanti, simile a quello del Sud e delle Isole (141,9 DDD) e superiore di circa il 37% rispetto al Centro Italia. Tuttavia, il calo complessivo del consumo di farmaci per l’osteoporosi è evidente in tutte le macroaree: -8,2% al Nord, -16,0% al Centro e -15,1% al Sud e nelle Isole. Nonostante ciò, la spesa complessiva si è ridotta in misura minore rispetto al consumo, con variazioni comprese tra lo 0,7% al Nord e il 4,9% al Sud e nelle Isole.
Aderenza al trattamento e tempo di persistenza
Nel 2023, il 67,9% degli utenti ha mantenuto un’alta aderenza alla terapia osteoporotica, un dato stabile rispetto all’anno precedente, con percentuali più elevate nelle donne. La persistenza media al trattamento varia tra le aree geografiche e tra i due sessi: le donne hanno una persistenza superiore ai 365 giorni, mentre negli uomini si attesta a 255 giorni. Nel Sud, il tempo mediano alla discontinuazione è inferiore rispetto ad altre aree (266 giorni).
Un settore in transizione
Il Rapporto OsMed 2023 fotografa un settore in transizione, con una riduzione dell’uso di vitamina D e un incremento nell’utilizzo di terapie innovative. I dati evidenziano la necessità di un uso più mirato e basato su evidenze scientifiche, specialmente per i farmaci vitaminici, e confermano la centralità delle terapie personalizzate, in particolare per le fasce di età più avanzate e per la popolazione femminile. L’incremento dell’uso di anticorpi monoclonali e di bifosfonati suggerisce una crescente attenzione alla qualità della terapia, con un focus verso trattamenti più efficaci e meno legati alle indicazioni tradizionali.


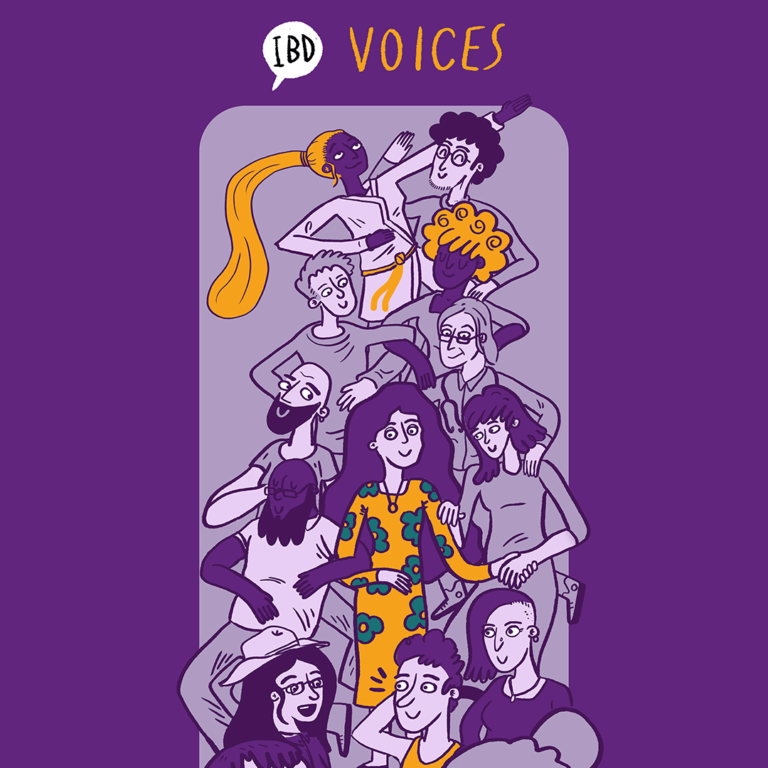
 “La colite ulcerosa (CU) colpisce in Italia più di 150.000 persone, con oltre 4.000 nuove diagnosi all’anno ed è in costante aumento in tutte le fasce d’età. Si tratta di una patologia ‘invisibile’ con sintomi invalidanti e imbarazzanti quali frequenza evacuativa, sanguinamento rettale e urgenza intestinale che hanno un forte impatto sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica, con la conseguenza di portare alcuni pazienti a isolamento sociale e autostigma. In alcuni casi, la colite ulcerosa progredisce fino a un grado di malattia da moderata a grave, per cui sono necessari interventi terapeutici in grado di agire rapidamente nel contrastare i sintomi più invalidanti”. È quanto afferma Cristina Bezzio, Medico Gastroenterologo presso IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, IBD Unit e Membro del Direttivo di Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD).
“La colite ulcerosa (CU) colpisce in Italia più di 150.000 persone, con oltre 4.000 nuove diagnosi all’anno ed è in costante aumento in tutte le fasce d’età. Si tratta di una patologia ‘invisibile’ con sintomi invalidanti e imbarazzanti quali frequenza evacuativa, sanguinamento rettale e urgenza intestinale che hanno un forte impatto sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica, con la conseguenza di portare alcuni pazienti a isolamento sociale e autostigma. In alcuni casi, la colite ulcerosa progredisce fino a un grado di malattia da moderata a grave, per cui sono necessari interventi terapeutici in grado di agire rapidamente nel contrastare i sintomi più invalidanti”. È quanto afferma Cristina Bezzio, Medico Gastroenterologo presso IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, IBD Unit e Membro del Direttivo di Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD). Per i clinici, affrontare la colite ulcerosa non significa solo trattare i sintomi intestinali ma considerare, e quando prossibile prevenire, anche le complicazioni a lungo termine, come l’osteoporosi. Monitorare la densità ossea, integrare calcio e vitamina D, e incoraggiare un’attività fisica adeguata possono fare una grande differenza nella vita dei pazienti. Inoltre, un dialogo empatico e informato può aiutare i pazienti a superare il senso di isolamento e migliorare il loro benessere globale.
Per i clinici, affrontare la colite ulcerosa non significa solo trattare i sintomi intestinali ma considerare, e quando prossibile prevenire, anche le complicazioni a lungo termine, come l’osteoporosi. Monitorare la densità ossea, integrare calcio e vitamina D, e incoraggiare un’attività fisica adeguata possono fare una grande differenza nella vita dei pazienti. Inoltre, un dialogo empatico e informato può aiutare i pazienti a superare il senso di isolamento e migliorare il loro benessere globale.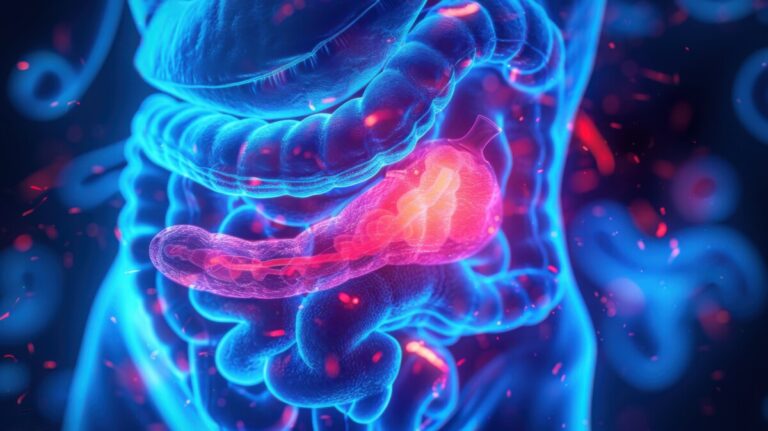


 Il numero di BoneHealth esplora i progressi della ricerca e le sfide cliniche nella gestione delle patologie ossee. Dalla prevenzione dell’osteoporosi alla gestione delle fratture da fragilità, il magazine offre un quadro aggiornato e approfondito per specialisti e operatori sanitari.
Il numero di BoneHealth esplora i progressi della ricerca e le sfide cliniche nella gestione delle patologie ossee. Dalla prevenzione dell’osteoporosi alla gestione delle fratture da fragilità, il magazine offre un quadro aggiornato e approfondito per specialisti e operatori sanitari.