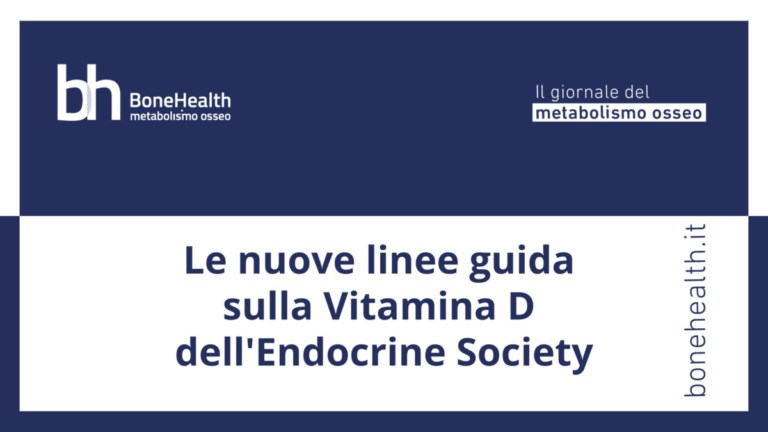Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha analizzato con tecnica HR-pQCT le alterazioni della microarchitettura ossea in 11 pazienti con acidosi tubulare distale ereditaria (dRTA) associata a mutazione del gene SLC4A1. I risultati mostrano una compromissione significativa del comparto trabecolare, più marcata rispetto a quella osservata nella rachitismo ipofosfatemico legato all’X (XLH). L’analisi ha evidenziato una riduzione della densità minerale ossea volumetrica (vBMD) e della qualità trabecolare a livello di radio e tibia distali, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e della terapia alcalinizzante.
Acidosi tubulare distale ereditaria
L’acidosi tubulare distale ereditaria (dRTA) associata a mutazione SLC4A1 rappresenta una rara ma insidiosa condizione metabolica con manifestazioni ossee spesso gravi, tra cui rachitismo, dolore, deformità e bassa statura. Meno noto, tuttavia, è l’impatto di questa condizione sulla microarchitettura ossea. A colmare questa lacuna interviene uno studio condotto presso il Peking Union Medical College Hospital e pubblicato sul JCEM, che ha impiegato la tomografia computerizzata periferica ad alta risoluzione (HR-pQCT) per valutare, per la prima volta, la struttura trabecolare e corticale in questi pazienti.
Uno studio comparativo con controlli e pazienti XLH
Lo studio ha incluso 11 pazienti con dRTA ereditaria confermata da mutazione SLC4A1, di cui 7 sottoposti ad HR-pQCT a livello di radio e tibia distali. I dati sono stati confrontati con quelli di 7 controlli sani e 21 pazienti affetti da XLH (X-linked hypophosphatemic rickets). I risultati hanno mostrato che nei pazienti con dRTA, la densità minerale ossea volumetrica trabecolare (Tb.vBMD) e il volume trabecolare relativo (Tb.BV/TV) erano significativamente ridotti, mentre la separazione trabecolare (Tb.Sp) risultava aumentata.
In particolare, al livello della tibia distale, la Tb.vBMD dei pazienti dRTA era di 91,7 mg HA/cm³ contro i 157,4 mg HA/cm³ dei controlli (p=0,015). La trabecolar number (Tb.N) era inferiore (1.037/mm vs 1.314/mm, p=0,004), mentre la trabecolar separation (Tb.Sp) risultava significativamente maggiore (0,962 mm vs 0,736 mm, p=0,004). Alterazioni simili, anche se meno marcate, sono state rilevate anche al radio distale.
dRTA vs XLH: danno trabecolare più severo
Il confronto con i pazienti XLH ha ulteriormente rafforzato le conclusioni. Nonostante entrambe le condizioni conducano a rachitismo e disfunzione scheletrica, i pazienti dRTA hanno mostrato una microarchitettura ossea trabecolare più compromessa. Alla tibia distale, il Tb.BV/TV era del 14,1% nei pazienti dRTA contro il 20,1% nei pazienti XLH (p=0,040), con trabecole più sottili e separate. Anche al radio, la Tb.Th era inferiore (0,206 mm vs 0,250 mm, p<0,001) e la porosità corticale significativamente più bassa nei dRTA (Ct.Po: 0,3% vs 1,4%, p=0,020), indicando una prevalente sofferenza trabecolare.
Terapia alcalinizzante: benefici concreti ma non risolutivi
I dati raccolti prima e dopo la somministrazione di terapia alcalinizzante (citrati o bicarbonato) mostrano un miglioramento clinico evidente. La crescita staturale (altezza Z-score da −2,5 a −1,7, p=0,043) e il sollievo dal dolore osseo sono stati riportati nella maggior parte dei pazienti. Tuttavia, nonostante l’aumento del pH ematico (da 7,26 a 7,37, p=0,017), gli indicatori di turnover osseo (ALP e β-CTX) non hanno mostrato variazioni statisticamente significative. Il miglioramento della densità ossea areale è stato osservato solo nei pochi pazienti con follow-up completo tramite DXA.
Un danno da acidosi cronica sottostimato
Il razionale patogenetico dello studio poggia sull’effetto della acidosi metabolica cronica sulla struttura ossea. In condizioni di acidemia persistente, il comparto scheletrico agisce da tampone, rilasciando bicarbonato e fosfato e generando una compromissione della mineralizzazione e un’alterazione della funzione osteocitaria. Risultati analoghi a quelli ottenuti nello studio HR-pQCT erano già stati osservati in modelli animali e in studi istomorfometrici su pazienti dRTA, che avevano evidenziato un’osteomalacia con incremento dell’osteoid volume e riduzione del bone formation rate.
Implicazioni cliniche: attenzione precoce e follow-up dedicato
Questo studio fornisce un contributo cruciale alla comprensione delle complicanze ossee nei pazienti con dRTA ereditaria da mutazione SLC4A1. La severità della compromissione trabecolare, superiore a quella osservata in pazienti XLH, suggerisce che la sola terapia alcalinizzante non sia sufficiente a ripristinare completamente la qualità ossea, sebbene rappresenti la prima e più importante linea di intervento. L’utilizzo sistematico della HR-pQCT, sebbene ancora confinato all’ambito della ricerca, potrebbe evolvere in futuro verso un uso clinico selettivo per monitorare questi pazienti in modo più accurato.
Quali scenari?
La dRTA da mutazione SLC4A1 deve essere considerata a tutti gli effetti una patologia ossea rara con fenotipo scheletrico importante. La sua diagnosi precoce, l’avvio tempestivo della terapia alcalinizzante e un monitoraggio radiologico mirato sono fondamentali per ridurre l’impatto delle alterazioni ossee, migliorare la qualità della vita e prevenire le deformità scheletriche permanenti. La severità del danno trabecolare osservato suggerisce inoltre la necessità di sviluppare approcci terapeutici complementari, mirati alla rimodulazione del turnover osseo e alla promozione della mineralizzazione.
Lo studio
Rong Chen, Lijia Cui, Juan Du, Shujie Zhang, Yan Jiang, Mei Li, Xiaoping Xing, Ou Wang, Weibo Xia, Alteration of Bone Microarchitecture in Hereditary Distal RTA Patients With SLC4A1 Gene Mutation: Assessed by HR-pQCT, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 110, Issue 5, May 2025, Pages e1358–e1366.