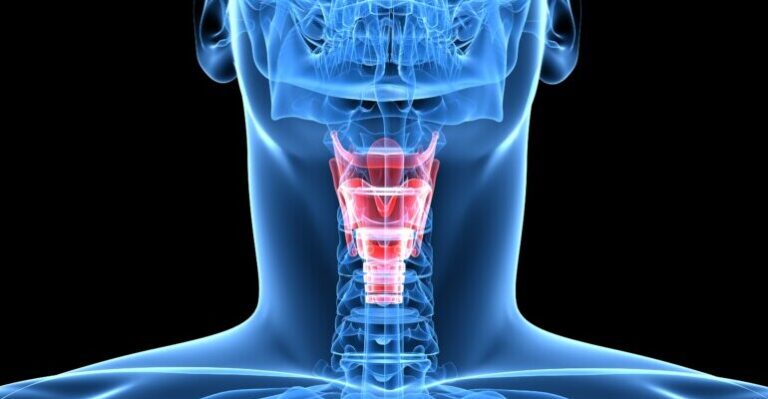Le fratture possono limitare l’indipendenza e il benessere psicologico di chi ne è colpito, anche molto significativamente. Queste conseguenze sono più studiate per quanto riguarda alcuni tipi di fratture, come quelle al femore e all’anca; altre, invece, sono poco conosciute, come quelle all’anello pelvico. Lo studio di Juliana Hack e colleghi, pubblicato su Osteoporosis International, ha indagato quanto la qualità di vita dei pazienti sia peggiorata dalle fratture della cintura pelvica.
La ricerca: scopo e metodi
Negli ultimi decenni stiamo assistendo a un aumento dell’età media della popolazione e a un cambiamento demografico. Per queste ragioni, i disturbi ossei legati all’invecchiamento stanno crescendo e sono sempre più studiati. Tra questi vi sono le fratture, che si presentano con l’avanzare dell’età a causa di vari fattori tra cui l’osteoporosi.
Le fratture della cintura pelvica sono tra le meno indagate. In particolare, sono poco studiati gli esiti dei trattamenti per quanto riguarda il benessere della persona. Juliana Hack e i suoi colleghi hanno indagato la percezione della propria qualità di vita nei pazienti post-fratture alla cintura pelvica e i fattori sottostanti.
A tale scopo, i ricercatori hanno reclutato 134 pazienti dall’ospedale universitario Giessen e Marburg GmbH tra il primo giugno 2012 e il 31 dicembre 2016. Sono stati esclusi i pazienti con fratture acetabolari isolate, traumi ad alta energia e fratture derivanti da cancro.
I pazienti, con età uguale o superiore a 60 anni (mediamente, 80) e trattati sia conservativamente sia chirurgicamente, sono stati esaminati prima della frattura (in modo retrospettivo) e poi a 6 settimane, 6 mesi e 12 mesi di distanza. Tra i fattori considerati:
- attività quotidiane compiute in autonomia (o ADL, Activities of Daily Living), valutate mediante Barthel Index e scala IADL (Lawton Instrumental Activities of Daily Living);
- stato di salute percepito dal paziente (tramite questionario EQ-5D).
Insieme all’analisi statistica, gli studiosi hanno estrapolato i fattori associabili a migliori o peggiori esiti delle fratture.
Qualità della vita e fratture alla cintura pelvica
I risultati della ricerca di Hack e colleghi mostrano che la maggior parte del recupero dei pazienti è avvenuto entro i 6 mesi dalla frattura all’anello pelvico. Anche il miglioramento della qualità della vita dopo la frattura è risultato concentrato in questo arco temporale. Tuttavia, non è risultato molto elevato: secondo le analisi, la frattura della cintura pelvica conduce a un deterioramento rilevante e duraturo dell’autonomia di chi ne è colpito.
A influire sull’esito risultano essere fattori quali:
- livelli di assistenza da parte di operatori sanitari prima della frattura;
- stato fisico, mobilità e attività antecedenti la frattura;
- sesso del paziente.
Infatti, alti livelli di assistenza, peggiore stato fisico, mobilità limitata e sesso maschile risultano peggiorare la qualità della vita post-frattura. Queste indicazioni possono essere utili allo scopo di prevenire fratture dell’anello pelvico.
Lo studio presenta diversi limiti, tra cui una parziale disomogeneità e il ristretto numero di pazienti (solo 89 di essi hanno raggiunto la fase finale dello studio). Tuttavia, mostra risultati interessanti, che forniscono indicazioni su provvedimenti da mettere in atto in ambito clinico e su aspetti da approfondire con ulteriori ricerche.
Fonte: