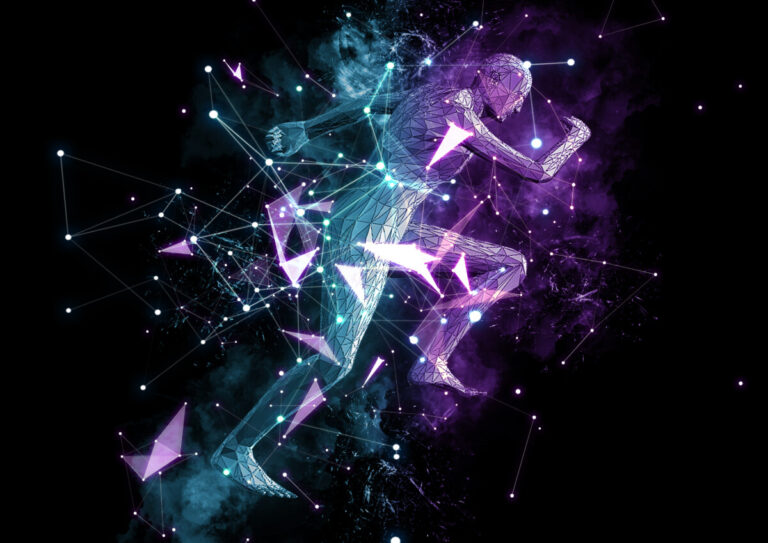Gli individui con diabete di tipo 2 (T2D) hanno un rischio maggiore di fratture ossee nonostante la densità minerale ossea normale o aumentata. Le cause non sono ancora ben comprese, ma potrebbero includere disturbi nell’asse intestino-osso, in cui sia il polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente (GIP) che il peptide-2 glucagone-simile (GLP-2) sono regolatori del turnover osseo.
Partendo da queste considerazioni, uno studio, che ha coinvolto 10 pazienti con diabete di tipo 2 (T2D), ha indagato gli effetti degli estrogeni GIP e GLP-2, somministrati per via sottocutanea: l’obiettivo dell’analisi è verificare l’incidenza di questi estrogeni sul turnover osseo in individui con T2D.
Risultati
Ai partecipanti sono stati iniettati per via sottocutanea GIP, GLP-2 o placebo a digiuno in 3 giorni di test separati: GIP e GLP-2 hanno ridotto significativamente il telopeptide C-terminale. Inoltre, Propeptide Aminoterminale Procollagene Tipo 1 e sclerostina sono aumentati acutamente dopo GIP, mentre è stata osservata una diminuzione di P1NP dopo GLP-2. I livelli di PTH sono scesi al 67 ± 2,5% del basale dopo GLP-2 e solo all’86 ± 3,4% dopo GIP.
In conclusione, quindi, si può sostenere che GIP e GLP-2 sottocutanei influenzano il collagene di tipo 1 (CTX e P1NP) negli individui con T2D nella stessa misura di quanto precedentemente dimostrato negli individui sani.
Lo studio
Kirsa Skov-Jeppesen, Charlotte B Christiansen, Laura S Hansen, Johanne A Windeløv, Nora Hedbäck, Lærke S Gasbjerg, Morten Hindsø, Maria S Svane, Sten Madsbad, Jens J Holst, Mette M Rosenkilde, Bolette Hartmann, Effects of Exogenous GIP and GLP-2 on Bone Turnover in Individuals With Type 2 Diabetes, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 109, Issue 7, July 2024, Pages 1773–1780.